Intervento di Gianluca Conte su ZONA DI DISAGIO, blog di Nicola Vacca
Carmelo Bene: essere altrove
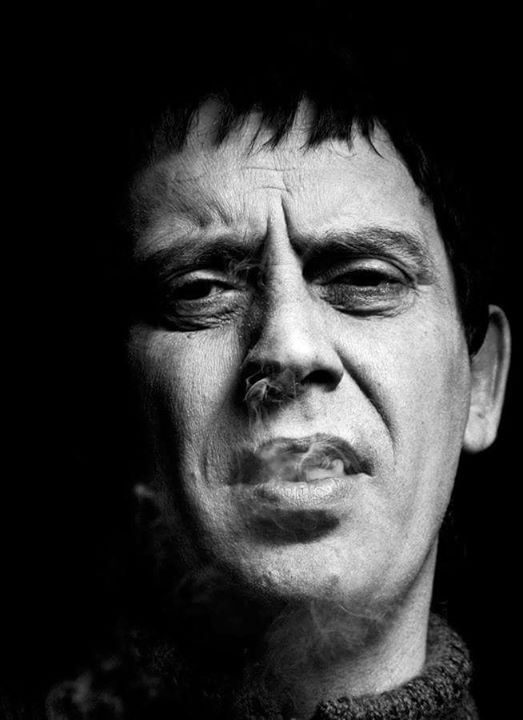
«Non essere dove si è, essere altrove,
smarrirsi per non più ritrovarsi». Il cammino umano e artistico di
Carmelo Bene andava nella direzione del de-collocarsi, del togliersi
dalla scena, dell’allontanarsi dal Sé. E non era affatto una via facile
da percorrere. Nel momento in cui Parmenide s’iniziò all’essere,
l’uomo incominciò a complicarsi l’esistenza. Carmelo Bene non aveva
nessun dubbio a riguardo: una miriade di questioni nasceva dal volersi
confrontare con una (ir)realtà così spinosa e vaga. Sono passati
millenni e il problema – ontologico, gnoseologico, etico, storico –
miete ancora vittime tra estimatori e detrattori, non ultimo Heidegger,
cui Bene rimandava a chi gli rompeva i cosiddetti con il Sein e
con l’ontologia. Poi, all’orizzonte, ecco pararsi la speculazione
deleuziana, impegnata nell’ardua prova di rivoltare uno dei più
stigmatizzanti dualismi filosofici e umani, quello “Io-Altro”, che aveva
trovato crogiuolo nell’universo antropocentrico occidentale (ma non
solo), e Carmelo Bene, incarnazione di rottura, lacerazione, fenditura,
trovò nel pensiero del filosofo francese materia di scambio e di
confronto (a modo suo, naturalmente). Non tutti i defunti sono buoni,
amabili e seguaci di rette vie, bisogna farsene una ragione. Nel caso
del nostro, poi, il disertare tutto ciò che era già stato battuto, anche
se attraente, rappresentava la “buona cattiveria”, il ghigno
liberatorio, contro la pseudo bontà dell’ufficialità e della cultura
generalista. Che Bene fosse la testimonianza vivente del potere
sovversivo dell’arte (ma guai a parlare del sociale e del politico
davanti al campiota) è cosa da tenere in grande considerazione, affinché
ricordare il maestro in occasione dell’anniversario della sua nascita
non diventi l’ennesima scritta sulla lapide di una memoria
istituzionalizzata e, cosa ben peggiore, edulcorata.
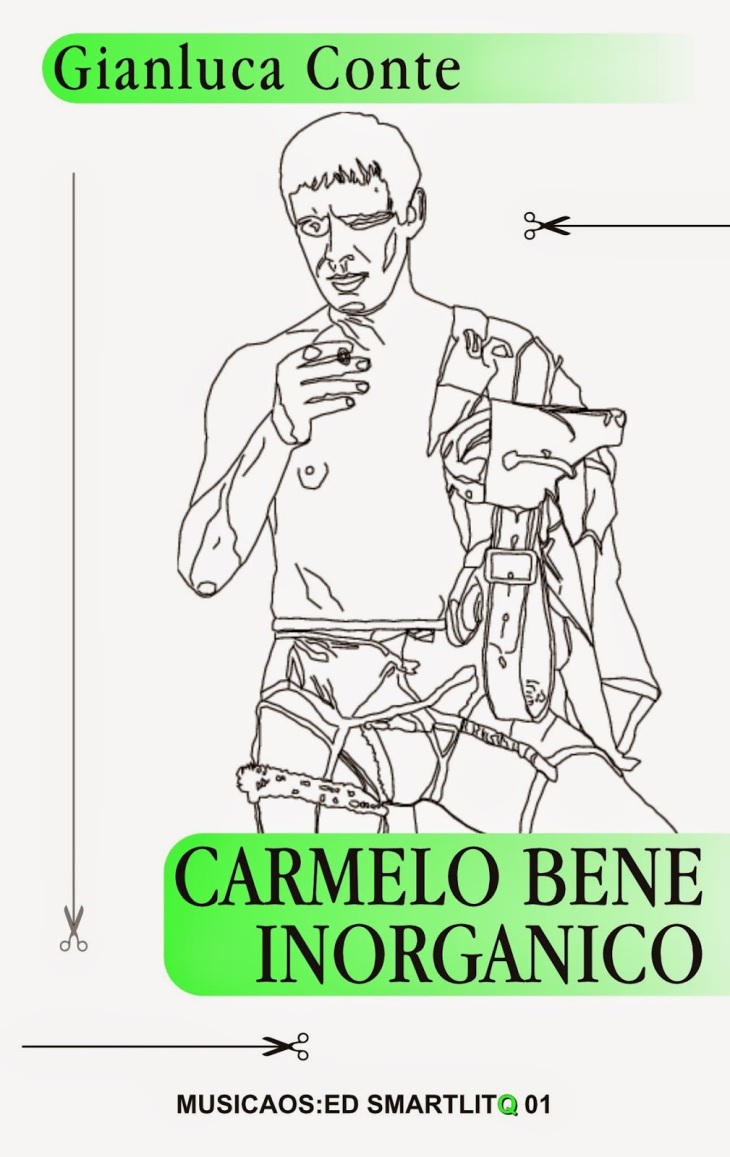
Quella di Bene è stata una figura unica,
irripetibile nella storia dell’arte: teatro, cinema, poesia, scrittura
e, suo malgrado, televisione hanno tribolato non poco sotto i colpi del
suo genio irrequieto, quasi teppistico. Attenzione: stiamo parlando di
arte non di cultura. Egli odiava quel termine così ambiguo, così
servile, fin nell’etimo. Più volte il nostro si era preoccupato di
associare la parola cultura al colonizzare e al colonizzato. Sorte
migliore non toccò all’informazione, soprattutto quella giornalistica,
vero male dei tempi (Nietzsche ne sapeva già qualcosa), cui il nostro
riservava grandiose stilettate. Tuttavia, Carmelo Bene non era solo un
provocatore, uno che si divertiva a farsi odiare, spesso riuscendoci.
Egli era un inattuale o, come lui stesso affermava (nevvero?), un
classico tra i classici e, cosa importantissima, vivente. E poi la voce,
quel grande, immenso organo di devastazione di stereotipi, di
abitudini, di conoscenze. Dare voce non tanto a Majakovskij o a Campana –
lì l’effetto era quasi scontato – ma a Leopardi è stato qualcosa di
dirompente, di inaspettatamente estremo. Trasformare l’Infinito
leopardiano in qualcosa di lunare, marziano, venusiano; trovarsi in
presenza di un Pierrot o-sceno che inquieta non solo le viscere ma la
mente; anticipare i tempi della tecnica, amplificando, meccanizzando,
disumanizzando pur servendosi di un cuore, di una bocca, di un volto:
tutto ciò ha del prodigioso. Farsi macchina attoriale e, forse, macchina
tout court, strizza l’occhio all’apocalisse dell’umano,
dimensione spazio-temporale dove valori e disvalori si annullano nel
sommo niente. Un niente dal sapore tutt’altro che pessimistico ma
futuristicamente primitivo, lontano, inattuale. Alfine, realizzare non
solo un annientamento della scena, del corpo, ma una scomposizione della
parola, del verbo, sostare presso un “Ni-Ente” che possa, in qualche
modo, portare all’avvento di quell’agape schopenhaueriana che di volta
in volta faceva capolino dalla macchina beniana. In questa dimensione
o-scena, de-strutturata, anche la morte, come noi la conosciamo (e
temiamo) non ha più senso, poiché è l’intero insieme della s-oggettità a
perdere senso. Chi ha la ventura di addentrarsi nell’opera di Bene può
godere di qualcosa che non troverà altrove: la sensazione vivida di
trovarsi di fronte a un’arte maledettamente autentica, folle e spietata.
E questo, a molti, fa paura.